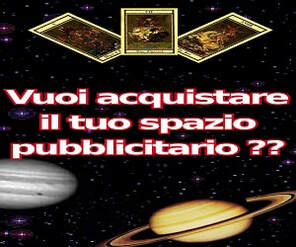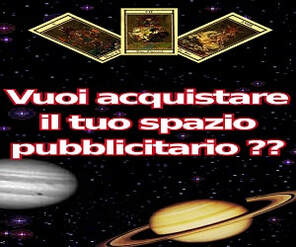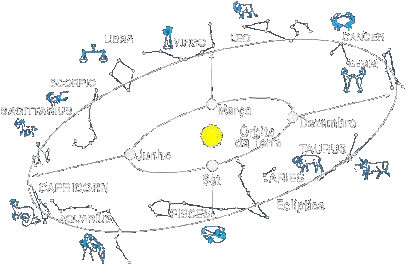
Con questo post mi rivolgo a tutti gli scettici prevenuti, a tutti i detrattori dell'astrologia sedicenti "dotti" che usano argomentazioni arbitrarie e senza cognizione di causa oppure, in modo premeditato, con la unica finalità di infondere confusione nell'opinione pubblica per ovvi (ai miei occhi) motivi reconditi, dando così prova di non aver minimamente studiato la storia o di essere in assoluta malafede. Certo è che se ci si deve guadagnare la pagnotta denigrando con tali modalità l'astrologia, è indice del fatto di aver fallito nel proprio mestiere, di non aver un benché minimo di talento in nulla!
Premetto che non mi è possibile, in questa sede, snocciolare l'argomento come si dovrebbe, per cui sono costretto ad essere molto sintetico, sperando di essere ugualmente esaustivo.
Innanzitutto ricordo che una delle tecniche di domificazione è stata messa a punto dal monaco benedettino Placido di Titi. Ma passiamo oltre.
Secondo la tradizione, una stella avrebbe guidato i tre re magi verso la grotta di Betlem; questi tre personaggi non erano dei sovrani, ma degli indovini d’Iran o di Babilonia, secondo il concetto antico dei sacerdoti. La stella dei magi forse non era altro che una cometa, oppure, secondo l’ipotesi di Keplero, una congiunzione eccezionale di pianeti (Giove, Marte, Saturno) che sovrapponendosi nel cielo acquisivano l’aspetto d’una unica stella gigante, di luce eccezionale. Comunque sia, gli astrologi notarono questo segno del cielo. L’inserimento dell’astrologia nella concezione cristiana del mondo ebbe fasi alterne: dapprima venne combattuta (concili di Laodicea 361, Toledo 400, Braga 561) e proibita con l’editto di Costantino, poi ebbe rapporti ufficiali con la religione. Gli uomini di Chiesa distinguevano tra le «naturalia» e le«contingentia», ammettevano che la predizione era possibile per i fenomeni naturali come malattie, fertilità, tempo, ma non per quello che dipendeva dal libero arbitrio umano. Gli avversari dell’astrologia pretendevano che essa insegnasse il determinismo, ma l’accusa non era sempre giusta e sincera. L’errore, dice lo storico Gleadow, era quello di considerare l’oroscopo come una storia scritta già in tutti i particolari, un romanzo di cui la fine è conosciuta prima che si cominci a leggerlo, e non come deve essere: una carta con cui un navigatore si dirige nel mezzo dei venti e delle correnti marine. Santa Hildgarde di Bingen scriveva che il Cristo aveva scelto per i suoi miracoli dei momenti astrologicamente favorevoli, avendo Egli detto: «Ci saranno dei Segni nel Sole e nella Luna e nelle stelle», e poiché la sua nascita fu annunciata da una stella era facile per molti cristiani credere all’astrologia. Helpericus, monaco del IX sec. i cui scritti concernono soprattutto il calendario della Chiesa, spiegò così il nome dei Segni zodiacali: l’Acquario, i Pesci per la stagione piovosa, il Leone per il caldo, la Bilancia per l’equinozio, il Cancro perché il Sole durante quel periodo comincia a ritornare indietro, il pungiglione dello Scorpione e la freccia del Sagittario sono paragonati alla puntura della grandine, il Capricorno è il punto più basso dove il Sole cambia direzione, e sempre verso l’alto delle montagne vanno a pascolare le capre. L’Ariete è chiamato così perché il Sole rompe il ghiaccio che ricopre la terra come un ariete all’attacco, le corna in avanti, sia perché gli arieti dopo aver passato le notti invernali coricati sul loro lato sinistro si girano allora su quello destro. Durante il mese del Toro i buoi lavorano per preparare la venuta delle messi. La spiegazione dei Gemelli differisce dalle altre e si limita all’evocazione di Castore e Polluce. La Vergine è chiamata infine così perché la Terra è esaurita e non porta più frutti (iniziando la trasformazione del carattere primitivo della giovane vergine in quello della matura). All’inizio del Medioevo il Sole era considerato come il simbolo del Cristo, e la Luna della Madonna. Contro l’astrologia furono S. Agostino, nello stesso spirito di Cicerone, ma altri padri della Chiesa, come il vescovo Syrnesius di Cirene, reputavano l’astrologia come una preparazione alla teologia, «se le stelle non potevano plasmare l’animo umano, potevano però influenzare il corpo e la volontà», diceva S. Alberto Magno, e il maggior teologo cristiano Tommaso d’Aquino riconobbe (nel «De causis») «che i corpi celesti sono la causa di tutto ciò che accade in questo mondo sublunare, e agiscono indirettamente sulle azioni umane; non tutti gli effetti da loro prodotti sono inevitabili».
Premetto che non mi è possibile, in questa sede, snocciolare l'argomento come si dovrebbe, per cui sono costretto ad essere molto sintetico, sperando di essere ugualmente esaustivo.
Innanzitutto ricordo che una delle tecniche di domificazione è stata messa a punto dal monaco benedettino Placido di Titi. Ma passiamo oltre.
Secondo la tradizione, una stella avrebbe guidato i tre re magi verso la grotta di Betlem; questi tre personaggi non erano dei sovrani, ma degli indovini d’Iran o di Babilonia, secondo il concetto antico dei sacerdoti. La stella dei magi forse non era altro che una cometa, oppure, secondo l’ipotesi di Keplero, una congiunzione eccezionale di pianeti (Giove, Marte, Saturno) che sovrapponendosi nel cielo acquisivano l’aspetto d’una unica stella gigante, di luce eccezionale. Comunque sia, gli astrologi notarono questo segno del cielo. L’inserimento dell’astrologia nella concezione cristiana del mondo ebbe fasi alterne: dapprima venne combattuta (concili di Laodicea 361, Toledo 400, Braga 561) e proibita con l’editto di Costantino, poi ebbe rapporti ufficiali con la religione. Gli uomini di Chiesa distinguevano tra le «naturalia» e le«contingentia», ammettevano che la predizione era possibile per i fenomeni naturali come malattie, fertilità, tempo, ma non per quello che dipendeva dal libero arbitrio umano. Gli avversari dell’astrologia pretendevano che essa insegnasse il determinismo, ma l’accusa non era sempre giusta e sincera. L’errore, dice lo storico Gleadow, era quello di considerare l’oroscopo come una storia scritta già in tutti i particolari, un romanzo di cui la fine è conosciuta prima che si cominci a leggerlo, e non come deve essere: una carta con cui un navigatore si dirige nel mezzo dei venti e delle correnti marine. Santa Hildgarde di Bingen scriveva che il Cristo aveva scelto per i suoi miracoli dei momenti astrologicamente favorevoli, avendo Egli detto: «Ci saranno dei Segni nel Sole e nella Luna e nelle stelle», e poiché la sua nascita fu annunciata da una stella era facile per molti cristiani credere all’astrologia. Helpericus, monaco del IX sec. i cui scritti concernono soprattutto il calendario della Chiesa, spiegò così il nome dei Segni zodiacali: l’Acquario, i Pesci per la stagione piovosa, il Leone per il caldo, la Bilancia per l’equinozio, il Cancro perché il Sole durante quel periodo comincia a ritornare indietro, il pungiglione dello Scorpione e la freccia del Sagittario sono paragonati alla puntura della grandine, il Capricorno è il punto più basso dove il Sole cambia direzione, e sempre verso l’alto delle montagne vanno a pascolare le capre. L’Ariete è chiamato così perché il Sole rompe il ghiaccio che ricopre la terra come un ariete all’attacco, le corna in avanti, sia perché gli arieti dopo aver passato le notti invernali coricati sul loro lato sinistro si girano allora su quello destro. Durante il mese del Toro i buoi lavorano per preparare la venuta delle messi. La spiegazione dei Gemelli differisce dalle altre e si limita all’evocazione di Castore e Polluce. La Vergine è chiamata infine così perché la Terra è esaurita e non porta più frutti (iniziando la trasformazione del carattere primitivo della giovane vergine in quello della matura). All’inizio del Medioevo il Sole era considerato come il simbolo del Cristo, e la Luna della Madonna. Contro l’astrologia furono S. Agostino, nello stesso spirito di Cicerone, ma altri padri della Chiesa, come il vescovo Syrnesius di Cirene, reputavano l’astrologia come una preparazione alla teologia, «se le stelle non potevano plasmare l’animo umano, potevano però influenzare il corpo e la volontà», diceva S. Alberto Magno, e il maggior teologo cristiano Tommaso d’Aquino riconobbe (nel «De causis») «che i corpi celesti sono la causa di tutto ciò che accade in questo mondo sublunare, e agiscono indirettamente sulle azioni umane; non tutti gli effetti da loro prodotti sono inevitabili».